(...) « L’Inviato ha Fede in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore, assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. “Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati!” E dicono: “Ascoltiamo e obbediamo! Il Tuo perdono, o nostro Signore! E verso di Te è il Divenire.”
L’Inviato ha Fede in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore, assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. “Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati!” E dicono: “Ascoltiamo e obbediamo! Il Tuo perdono, o nostro Signore! E verso di Te è il Divenire.”  Allah non impone ad un’anima se non ciò di cui essa è capace: ad essa va ciò che consegue, e contro di essa è ciò che commette. “O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo! O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi! O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere! Usaci clemenza, perdonaci e di noi abbi Misericordia! Tu sei il nostro Patrono: dacci vittoria sul popolo dei negatori!»
Allah non impone ad un’anima se non ciò di cui essa è capace: ad essa va ciò che consegue, e contro di essa è ciò che commette. “O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo! O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi! O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere! Usaci clemenza, perdonaci e di noi abbi Misericordia! Tu sei il nostro Patrono: dacci vittoria sul popolo dei negatori!»
I versetti 285 e 286. Commento di Ibn Kathîr
Menzione degli hadith che riguardano l’eccellenza di questi due versetti, che Allah faccia sì che ci rechino giovamento!
Primo hadith. Al-Bukhârî tramanda [nel Sahîh (60, X, 5009)] da Abû Mas‘ûd che il Profeta disse: “Chi durante la notte recita i due ultimi versetti della Sura della Vacca Sacrificale, essi gli saranno sufficienti.” Lo tramandano anche altri tradizionisti [tra i quali Muslim (6, XLIII, 808) e Abû Dâwud (1397)] con una differente catena di trasmettitori (…).
disse: “Chi durante la notte recita i due ultimi versetti della Sura della Vacca Sacrificale, essi gli saranno sufficienti.” Lo tramandano anche altri tradizionisti [tra i quali Muslim (6, XLIII, 808) e Abû Dâwud (1397)] con una differente catena di trasmettitori (…).
Secondo hadith. Ibn Hanbal tramanda da Abû Dharr che l’Inviato di Allah disse: “I versetti finali della Sura della Vacca sacrificale mi sono stati donati da un Tesoro sotto il Trono. Essi non sono stati concessi a nessun Profeta prima di me.” (…)
disse: “I versetti finali della Sura della Vacca sacrificale mi sono stati donati da un Tesoro sotto il Trono. Essi non sono stati concessi a nessun Profeta prima di me.” (…)
Terzo hadith. Muslim (1, LXXII, 173) tramanda da Ibn Mas‘ûd: “Durante il Viaggio notturno, l’Inviato di Allah fu portato sino al Loto del Limite (سدرة المنتهى sidratu l-muntahâ), nel sesto Cielo.[1] Ad esso giunge ciò che sale dalla terra e viene afferrato dal Loto, come quel che scende da sopra il Loto ed egualmente viene afferrato da esso, «laddove copre il Loto ciò che lo copre» (LIII, 15), e cioè farfalline d’oro. Allora vennero date all’Inviato di Allah
fu portato sino al Loto del Limite (سدرة المنتهى sidratu l-muntahâ), nel sesto Cielo.[1] Ad esso giunge ciò che sale dalla terra e viene afferrato dal Loto, come quel che scende da sopra il Loto ed egualmente viene afferrato da esso, «laddove copre il Loto ciò che lo copre» (LIII, 15), e cioè farfalline d’oro. Allora vennero date all’Inviato di Allah tre cose: gli vennero date le cinque preghiere, gli vennero concessi i versetti conclusivi della Sura della Vacca sacrificale, e vennero perdonati, a coloro che della sua Comunità non associano nulla ad Allah, i peccati gravi che portan chi li compie alla rovina (المقحمات al-muqhimât).”
tre cose: gli vennero date le cinque preghiere, gli vennero concessi i versetti conclusivi della Sura della Vacca sacrificale, e vennero perdonati, a coloro che della sua Comunità non associano nulla ad Allah, i peccati gravi che portan chi li compie alla rovina (المقحمات al-muqhimât).”
Quarto hadith. Ibn Hanbal tramanda da ‘Uqba ibn ‘Âmir che l’Inviato di Allah disse: “Recitate i due versetti finali della Sura della Vacca Sacrificale: mi sono stati dati da un Tesoro sotto il Trono.” La catena dei trasmettitori del hadith è affidabile (…).
disse: “Recitate i due versetti finali della Sura della Vacca Sacrificale: mi sono stati dati da un Tesoro sotto il Trono.” La catena dei trasmettitori del hadith è affidabile (…).
Quinto hadith. Ibn Mardawayh tramanda da Hudhayfa che l’Inviato di Allah disse: “Siamo stati preferiti a[l resto de]gli uomini per tre cose: mi sono stati dati questi versetti che concludono la Sura della Vacca Sacrificale da una Camera del Tesoro sotto il Trono. Non sono stati concessi a nessuno prima di me, e non saranno dati a nessuno dopo di me.” (…)
disse: “Siamo stati preferiti a[l resto de]gli uomini per tre cose: mi sono stati dati questi versetti che concludono la Sura della Vacca Sacrificale da una Camera del Tesoro sotto il Trono. Non sono stati concessi a nessuno prima di me, e non saranno dati a nessuno dopo di me.” (…)
Sesto hadith. Ibn Mardawayh tramanda da ‘Alî: “Non ha mai visto nessuno che comprendesse l’Islam e dormisse senza recitare il Versetto dello Sgabello e i versetti conclusivi della Sura della Vacca Sacrificale: essi vengono da un Tesoro ricevuto dal vostro Profeta da sotto il Trono.” (…)
da sotto il Trono.” (…)
Settimo hadith. At-Tirmidhî tramanda da An-Nu‘mân ibn Bashîr che il Profeta disse: “Duemila anni prima di creare i Cieli e la terra Allah plasmò uno Scritto, dal quale fece discendere i due versetti che concludono la Sura della Vacca Sacrificale: se essi vengono recitati in una dimora per tre notti il demonio non le si avvicina.” At-Tirmidhî considera la catena dei trasmettitori non del tutto affidabile, ma Al-Hâkim lo tramanda nel Mustadrak affermando viceversa che il hadith è ‘buono’ (…).
disse: “Duemila anni prima di creare i Cieli e la terra Allah plasmò uno Scritto, dal quale fece discendere i due versetti che concludono la Sura della Vacca Sacrificale: se essi vengono recitati in una dimora per tre notti il demonio non le si avvicina.” At-Tirmidhî considera la catena dei trasmettitori non del tutto affidabile, ma Al-Hâkim lo tramanda nel Mustadrak affermando viceversa che il hadith è ‘buono’ (…).
Ottavo hadith. Ibn Mardawayh tramanda da Ibn ‘Abbâs: “Quando l’Inviato di Allah recitava la chiusa della Sura della Vacca Sacrificale e il Versetto dello Sgabello, sorrideva e diceva: ‘Vengono dal Tesoro del Misericordioso, sotto il Trono!’ Quando invece recitava le Parole «Chi commette mala opera ne paga il fio» (IV, 123), e le Parole «E [non gli è stata data notizia] che l’uomo non ha se non per ciò che si sforza? E che il suo sforzo sarà veduto, quindi ne avrà la più compiuta delle retribuzioni?» (LIII, 39-41), diceva ‘Noi apparteniamo ad Allah, e a Lui facciamo ritorno!’, e si umiliava davanti a Dio.”
recitava la chiusa della Sura della Vacca Sacrificale e il Versetto dello Sgabello, sorrideva e diceva: ‘Vengono dal Tesoro del Misericordioso, sotto il Trono!’ Quando invece recitava le Parole «Chi commette mala opera ne paga il fio» (IV, 123), e le Parole «E [non gli è stata data notizia] che l’uomo non ha se non per ciò che si sforza? E che il suo sforzo sarà veduto, quindi ne avrà la più compiuta delle retribuzioni?» (LIII, 39-41), diceva ‘Noi apparteniamo ad Allah, e a Lui facciamo ritorno!’, e si umiliava davanti a Dio.”
Nono hadith. Ibn Mardawayh tramanda da Ma‘qal ibn Yasâr che l’Inviato di Allah disse: “Mi son stati concessi la [Sura] Aprente il Libro e i versetti conclusivi della Sura della Vacca Sacrificale, da sotto il Trono; e ancora la [sezione del Corano detta] mufassal,[2] in aggiunta.”
disse: “Mi son stati concessi la [Sura] Aprente il Libro e i versetti conclusivi della Sura della Vacca Sacrificale, da sotto il Trono; e ancora la [sezione del Corano detta] mufassal,[2] in aggiunta.”
Decimo hadith. Parlando dell’eccellenza della Sura Aprente, abbiamo già riportato da Ibn ‘Abbâs: “L’Inviato di Allah era con noi, e presso di lui c’era Gibrîl. Ad un tratto udì un rumore sopra di lui; Gibrîl alzò lo sguardo al Cielo, e disse: ‘S’è aperta in Cielo una Porta che non s’era mai aperta prima.’ Da tale Porta discese un Angelo, venne dal Profeta
era con noi, e presso di lui c’era Gibrîl. Ad un tratto udì un rumore sopra di lui; Gibrîl alzò lo sguardo al Cielo, e disse: ‘S’è aperta in Cielo una Porta che non s’era mai aperta prima.’ Da tale Porta discese un Angelo, venne dal Profeta e disse: ‘Rallegrati per due Luci che sono state date a te, e non sono state date a nessun altro Profeta prima di te: l’Aprente del Libro, e gli ultimi versetti della Sura della Vacca Sacrificale. Non ne reciti neppure una lettera che non ti sia stata donata.’ ” Lo tramandano Muslim [nel suo Sahîh (6, XLIII, 806)] e An-Nasâ’î, e questo è il testo riportato da An-Nasâ’î.
e disse: ‘Rallegrati per due Luci che sono state date a te, e non sono state date a nessun altro Profeta prima di te: l’Aprente del Libro, e gli ultimi versetti della Sura della Vacca Sacrificale. Non ne reciti neppure una lettera che non ti sia stata donata.’ ” Lo tramandano Muslim [nel suo Sahîh (6, XLIII, 806)] e An-Nasâ’î, e questo è il testo riportato da An-Nasâ’î.
Undicesimo hadith. Ad-Dârimî tramanda da Ayfa‘: “Un uomo chiese: ‘Inviato di Allah, quale versetto del Libro di Allah è più magnifico?’ Lui rispose: ‘Il Versetto dello Sgabello: «Allah, non v’è divinità all’infuori di Lui, il Vivente, Colui che da Sé sussiste» (II, 255).’ L’uomo chiese ancora: ‘E quale versetto nel Libro di Allah ameresti che cogliesse te e la tua Comunità?’ Lui disse: ‘La chiusa della Sura della Vacca Sacrificale: essa non lascia nessun Bene del basso mondo e dell’Oltre senza comprenderlo.’ ”
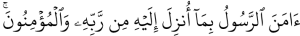 [Venendo al testo dei versetti,] Allah l’Altissimo dice: «L’Inviato ha Fede in quel ch’è stato fatto discender su di lui dal suo Signore». Dà dunque notizia del Profeta
[Venendo al testo dei versetti,] Allah l’Altissimo dice: «L’Inviato ha Fede in quel ch’è stato fatto discender su di lui dal suo Signore». Dà dunque notizia del Profeta . At-Tabarî tramanda da Qatâda: “Ci è stato riferito che quando discese su di lui questo versetto, l’Inviato di Allah
. At-Tabarî tramanda da Qatâda: “Ci è stato riferito che quando discese su di lui questo versetto, l’Inviato di Allah disse: ‘E davvero è opportuno per lui avere Fede!’ ” (…). Poi aggiunge «Assieme ai credenti», accostando la loro menzione a quella dell’Inviato.
disse: ‘E davvero è opportuno per lui avere Fede!’ ” (…). Poi aggiunge «Assieme ai credenti», accostando la loro menzione a quella dell’Inviato.
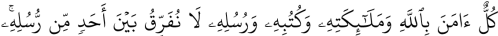 Dopo di che parlando di tutti loro dice: «Ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. “Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati!”» I credenti hanno Fede che Allah sia Uno, Unico, Singolare, Tale che a Lui tende ogni cosa: non v’è divinità all’infuori di Lui, e non v’è Signore altri che Lui! Essi inoltre confermano tutti i Profeti, tutti gli Inviati divini, tutti i Libri discesi dal Cielo sui servi di Allah che sono Inviati divini e Profeti, senza far differenza tra loro, e cioè senza credere in alcuni e smentire gli altri: piuttosto, per loro tutti gli Inviati e i Profeti sono veritieri, pii, orientati, guidati e capaci di guidare alla Via del Bene, anche se alcuni di loro abrogano le Leggi sacre di altri, col Permesso di Allah, sino a che tutte le Leggi sacre sono abrogate dalla Legge sacra di Muhammad
Dopo di che parlando di tutti loro dice: «Ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. “Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati!”» I credenti hanno Fede che Allah sia Uno, Unico, Singolare, Tale che a Lui tende ogni cosa: non v’è divinità all’infuori di Lui, e non v’è Signore altri che Lui! Essi inoltre confermano tutti i Profeti, tutti gli Inviati divini, tutti i Libri discesi dal Cielo sui servi di Allah che sono Inviati divini e Profeti, senza far differenza tra loro, e cioè senza credere in alcuni e smentire gli altri: piuttosto, per loro tutti gli Inviati e i Profeti sono veritieri, pii, orientati, guidati e capaci di guidare alla Via del Bene, anche se alcuni di loro abrogano le Leggi sacre di altri, col Permesso di Allah, sino a che tutte le Leggi sacre sono abrogate dalla Legge sacra di Muhammad , sigillo dei Profeti e degli Inviati, sulla cui Legge sacra si leverà l’Ora, mentre vi sarà una parte di quelli della sua Comunità che permarranno vittoriosi secondo il Vero.
, sigillo dei Profeti e degli Inviati, sulla cui Legge sacra si leverà l’Ora, mentre vi sarà una parte di quelli della sua Comunità che permarranno vittoriosi secondo il Vero.
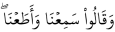 «E dicono: “Ascoltiamo e obbediamo!”», e cioè: ‘O nostro Signore, abbiamo udito le Tue Parole, le abbiamo comprese, ci leviamo ad esse e in base a quel che esse impongono operiamo.
«E dicono: “Ascoltiamo e obbediamo!”», e cioè: ‘O nostro Signore, abbiamo udito le Tue Parole, le abbiamo comprese, ci leviamo ad esse e in base a quel che esse impongono operiamo.
 «“Il Tuo Perdono, o nostro Signore!”»: qui si chiede a Dio il Perdono, la Misericordia e la Delicatezza. Secondo quanto si riporta da Ibn ‘Abbâs, alle parole «“Il Tuo Perdono, o nostro Signore”», Allah dice: “Sì, vi ho già perdonato!”
«“Il Tuo Perdono, o nostro Signore!”»: qui si chiede a Dio il Perdono, la Misericordia e la Delicatezza. Secondo quanto si riporta da Ibn ‘Abbâs, alle parole «“Il Tuo Perdono, o nostro Signore”», Allah dice: “Sì, vi ho già perdonato!”
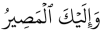 «“E verso di Te è il Divenire”», e cioè verso di Te è il Ritorno e il Rifugio il Giorno del Rendiconto.
«“E verso di Te è il Divenire”», e cioè verso di Te è il Ritorno e il Rifugio il Giorno del Rendiconto.
At-Tabarî tramanda da Giâbir: “Quando discesero le Parole «L’Inviato ha Fede in quel ch’è stato fatto discender su di lui» ecc., Gibrîl disse: ‘Allah ha fatto magnifico elogio di te e della tua Comunità: chiedigli dunque, che ti sarà dato!’ Egli allora chiese: «Allah non impone ad un’anima se non ciò di cui essa è capace» ecc., sino al termine del versetto.”
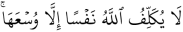 Dice dunque: «Allah non impone ad un’anima se non ciò di cui essa è capace», e cioè a nessuno vien fatto sopportare più di quel che può sopportare. Questo fa parte della delicatezza, della tenerezza e della perfetta bontà dell’Altissimo con le Sue creature: sono queste le parole che abrogano e levano quello che i Compagni del Profeta
Dice dunque: «Allah non impone ad un’anima se non ciò di cui essa è capace», e cioè a nessuno vien fatto sopportare più di quel che può sopportare. Questo fa parte della delicatezza, della tenerezza e della perfetta bontà dell’Altissimo con le Sue creature: sono queste le parole che abrogano e levano quello che i Compagni del Profeta temevano alla rivelazione del versetto in cui si diceva «Che manifestiate ciò che avete in animo o che lo nascondiate, Allah ve ne chiede conto» (II, 283). Il senso dunque è che Egli chiede conto e domanda, ma non punisce se non per quello che l’individuo riesce a respingere. Viceversa, quei suggerimenti dell’animo che non è in suo potere respingere, ecco che l’uomo non ne porta responsabilità, benché faccia parte della Fede provar disappunto e contrarietà per i pensieri cattivi.
temevano alla rivelazione del versetto in cui si diceva «Che manifestiate ciò che avete in animo o che lo nascondiate, Allah ve ne chiede conto» (II, 283). Il senso dunque è che Egli chiede conto e domanda, ma non punisce se non per quello che l’individuo riesce a respingere. Viceversa, quei suggerimenti dell’animo che non è in suo potere respingere, ecco che l’uomo non ne porta responsabilità, benché faccia parte della Fede provar disappunto e contrarietà per i pensieri cattivi.
 Poi dice che all’anima «va ciò che consegue» di Bene, «e contro di essa è ciò che commette» di male, e si intendono le opere che rientrano nell’ambito di quello di cui si è legalmente responsabili.
Poi dice che all’anima «va ciò che consegue» di Bene, «e contro di essa è ciò che commette» di male, e si intendono le opere che rientrano nell’ambito di quello di cui si è legalmente responsabili.
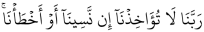 Quindi l’Altissimo guida i Suoi servi a chiedere, garantendo risposta affermativa. Insegna loro dunque a dire: «“O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo!”», e cioè se tralasciamo qualcosa di obbligatorio, o commettiamo qualcosa di vietato, per dimenticanza, oppure se sbagliamo e non facciamo quel che è giusto fare, nelle opere, per ignoranza da parte nostra di quel che afferma la Legge sacra. E come abbiamo già riportato dal Sahîh di Muslim, secondo quel che tramanda Abû Hurayra “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, mentre secondo quel che tramanda Ibn ‘Abbâs dice “Già fatto!”
Quindi l’Altissimo guida i Suoi servi a chiedere, garantendo risposta affermativa. Insegna loro dunque a dire: «“O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo!”», e cioè se tralasciamo qualcosa di obbligatorio, o commettiamo qualcosa di vietato, per dimenticanza, oppure se sbagliamo e non facciamo quel che è giusto fare, nelle opere, per ignoranza da parte nostra di quel che afferma la Legge sacra. E come abbiamo già riportato dal Sahîh di Muslim, secondo quel che tramanda Abû Hurayra “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, mentre secondo quel che tramanda Ibn ‘Abbâs dice “Già fatto!”
Si tramanda da Ibn ‘Abbâs nelle Sunan di Ibnu Mâgiah, nel Sahîh di Ibn Hibbân e nel testo di At-Tabarânî, con diverse catene di trasmettitori, che l’Inviato di Allah disse: “Allah ha tolto dalla responsabilità della mia Comunità l’errore, la dimenticanza e ciò di cui hanno avversione.” (…)
disse: “Allah ha tolto dalla responsabilità della mia Comunità l’errore, la dimenticanza e ciò di cui hanno avversione.” (…)
Ibn Abî Hâtim tramanda da Ummu d-Dardâ’ che il Profeta disse: “Invero Allah passa oltre, per la mia Comunità, all’errore, alla dimenticanza e a quello di cui si ha avversione.” Abû Bakr disse: “Menzionai questo ad Al-Hasan, e lui mi disse: ‘Certamente! Non reciti le parole «O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo»?’ ”
disse: “Invero Allah passa oltre, per la mia Comunità, all’errore, alla dimenticanza e a quello di cui si ha avversione.” Abû Bakr disse: “Menzionai questo ad Al-Hasan, e lui mi disse: ‘Certamente! Non reciti le parole «O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo»?’ ”
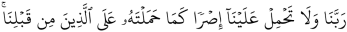 Poi dice: «“O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi!”» Il senso è ‘Non imporci opere gravose che potremmo mettere in atto solo sforzandoci molto, così come hai fatto con le Comunità che ci hanno preceduto, per le quali hai stabilito catene e patti gravi. Tu hai poi mandato il Tuo Profeta Muhammad
Poi dice: «“O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi!”» Il senso è ‘Non imporci opere gravose che potremmo mettere in atto solo sforzandoci molto, così come hai fatto con le Comunità che ci hanno preceduto, per le quali hai stabilito catene e patti gravi. Tu hai poi mandato il Tuo Profeta Muhammad , Profeta della Misericordia, a togliere queste cose dalla sua Legge sacra, con la quale lo hai inviato: e si tratta della Religione primordiale ed universale, facile e tollerante.
, Profeta della Misericordia, a togliere queste cose dalla sua Legge sacra, con la quale lo hai inviato: e si tratta della Religione primordiale ed universale, facile e tollerante.
Anche qui, nel Sahîh di Muslim si tramanda dall’Inviato di Allah , secondo quel che tramanda Abû Hurayra, che “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, mentre secondo quel che tramanda Ibn ‘Abbâs Egli dice “Già fatto!”
, secondo quel che tramanda Abû Hurayra, che “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, mentre secondo quel che tramanda Ibn ‘Abbâs Egli dice “Già fatto!”
In un noto hadith, si tramanda con varie catene di trasmettitori che l’Inviato di Allah disse: “Son stato mandato con la Religione primordiale ed universale, pienamente tollerante (الحنيفية السمحة al-hanîfiyyatu s-samha).”
disse: “Son stato mandato con la Religione primordiale ed universale, pienamente tollerante (الحنيفية السمحة al-hanîfiyyatu s-samha).”
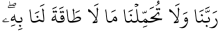 Quindi dice: «“O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere!”», che si tratti di imposizioni sacre, di avversità o di prove che non possiamo sopportare. Secondo Makhûl il riferimento è all’esilio e al [divieto del] desiderio carnale. Ancora, “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, oppure, secondo l’altro hadith: “Già fatto!”
Quindi dice: «“O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere!”», che si tratti di imposizioni sacre, di avversità o di prove che non possiamo sopportare. Secondo Makhûl il riferimento è all’esilio e al [divieto del] desiderio carnale. Ancora, “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, oppure, secondo l’altro hadith: “Già fatto!”
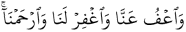 Poi dice: «“Usaci Clemenza”» quanto al rapporto tra Te e noi, per quelle nostre mancanze e per quelle nostre cadute che ben conosci; «“perdonaci”» quanto al rapporto tra noi e i Tuoi servi, e non rivelare loro le nostre azioni cattive, né le nostre male opere; «“e di noi abbi Misericordia”» nel futuro, e grazie al Tuo Sostengo non farci cadere in altri peccati. Si dice infatti che il peccatore ha bisogno di tre cose: che Allah gli usi Clemenza in quello che riguarda il rapporto con Lui, che lo copra di un velo con i Suoi servi di modo da non divulgar tra loro i suoi peccati, e che lo protegga non facendolo più cadere in qualcosa di simile. Anche qui, “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, oppure, secondo l’altro hadith: “Già fatto!”
Poi dice: «“Usaci Clemenza”» quanto al rapporto tra Te e noi, per quelle nostre mancanze e per quelle nostre cadute che ben conosci; «“perdonaci”» quanto al rapporto tra noi e i Tuoi servi, e non rivelare loro le nostre azioni cattive, né le nostre male opere; «“e di noi abbi Misericordia”» nel futuro, e grazie al Tuo Sostengo non farci cadere in altri peccati. Si dice infatti che il peccatore ha bisogno di tre cose: che Allah gli usi Clemenza in quello che riguarda il rapporto con Lui, che lo copra di un velo con i Suoi servi di modo da non divulgar tra loro i suoi peccati, e che lo protegga non facendolo più cadere in qualcosa di simile. Anche qui, “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, oppure, secondo l’altro hadith: “Già fatto!”
 Poi dice: «“Tu sei il nostro Patrono”». E cioè sei il nostro Amico e il nostro Soccorso, a Te ci affidiamo fiduciosi, a Te chiediamo aiuto, e in Te riponiamo Fiducia: e non v’è forza né potenza se non in Te.
Poi dice: «“Tu sei il nostro Patrono”». E cioè sei il nostro Amico e il nostro Soccorso, a Te ci affidiamo fiduciosi, a Te chiediamo aiuto, e in Te riponiamo Fiducia: e non v’è forza né potenza se non in Te.
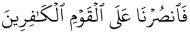 Infine dice: «“Dacci vittoria sul popolo dei negatori”», quelli cioè che rinnegano la Tua Religione, non rispettano la Tua Unità, e neppure la missione del Tuo Profeta, adorando altri che Te ed associando a te certi Tuoi servi. Dacci dunque aiuto contro di loro, e fai che l’Esito in questo mondo e nell’Oltre sia contro di loro e a nostro favore. E “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, oppure, secondo l’altro hadith riportato da Muslim: “Già fatto!”
Infine dice: «“Dacci vittoria sul popolo dei negatori”», quelli cioè che rinnegano la Tua Religione, non rispettano la Tua Unità, e neppure la missione del Tuo Profeta, adorando altri che Te ed associando a te certi Tuoi servi. Dacci dunque aiuto contro di loro, e fai che l’Esito in questo mondo e nell’Oltre sia contro di loro e a nostro favore. E “Allah dice a queste parole ‘Sì’ ”, oppure, secondo l’altro hadith riportato da Muslim: “Già fatto!”
At-Tabarî tramanda da quando Mu‘âdh terminava la Sura recitando «“Dacci vittoria sul popolo dei negatori”», diceva “Âmîn!” (…)
I vv. 285 e 286: citazioni da altri commentari e nostre osservazioni, sulla base di Ibn Kathîr:
֎ “I versetti finali della Sura della Vacca sacrificale mi sono stati donati da un Tesoro sotto il Trono”. Come riporta Al-Qurtubî, dissero al Profeta che la casa di Thâbit ibn Qays ogni notte era illuminata come da lampade, e lui disse: “Può ben essere che reciti la Sura della Vacca Sacrificale!” Chiesero allora a Thâbit, che disse: “Della Sura della Vacca Sacrificale stavo leggendo «L’Inviato ha Fede in quel ch’è stato fatto discender su di lui dal suo Signore» ecc.” Al-Alûsî tramanda da Abû Dharr sull’autorità di Al-Bayhaqî che l’Inviato di Allah
che la casa di Thâbit ibn Qays ogni notte era illuminata come da lampade, e lui disse: “Può ben essere che reciti la Sura della Vacca Sacrificale!” Chiesero allora a Thâbit, che disse: “Della Sura della Vacca Sacrificale stavo leggendo «L’Inviato ha Fede in quel ch’è stato fatto discender su di lui dal suo Signore» ecc.” Al-Alûsî tramanda da Abû Dharr sull’autorità di Al-Bayhaqî che l’Inviato di Allah disse: “Allah ha concluso la Sura della Vacca Sacrificale con due versetti che mi ha dato dal Suo Tesoro che si trova sotto il Trono: imparateli, ed insegnateli alle vostre donne ed ai vostri figli, che essi sono Preghiera, e Corano, e Invocazione.” In una versione che si riporta da Muhammad ibn Al-Munkadir, egli dice: “Essi sono Corano, e sono Invocazione: fanno entrare in Paradiso, e dan Soddisfazione al Misericordioso.” Un aspetto particolare dell’eccellenza dei due versetti finali della seconda Sura si desume dai dati tradizionali che li vedono come ispirati direttamente (e dunque senza la mediazione dell’Angelo) durante l’Ascensione profetica. Dice Ismâ‘îl Haqqî: “Racconta l’Inviato di Allah
disse: “Allah ha concluso la Sura della Vacca Sacrificale con due versetti che mi ha dato dal Suo Tesoro che si trova sotto il Trono: imparateli, ed insegnateli alle vostre donne ed ai vostri figli, che essi sono Preghiera, e Corano, e Invocazione.” In una versione che si riporta da Muhammad ibn Al-Munkadir, egli dice: “Essi sono Corano, e sono Invocazione: fanno entrare in Paradiso, e dan Soddisfazione al Misericordioso.” Un aspetto particolare dell’eccellenza dei due versetti finali della seconda Sura si desume dai dati tradizionali che li vedono come ispirati direttamente (e dunque senza la mediazione dell’Angelo) durante l’Ascensione profetica. Dice Ismâ‘îl Haqqî: “Racconta l’Inviato di Allah negli hadith riguardanti l’Ascensione: [Quando ebbi superato il Loto del Limite,] Allah mi fece avvicinare, mi approssimò al sostegno del Trono, poi mi ispirò di dire ‘«L’Inviato ha Fede in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore, assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati», come invece facevano gli Ebrei e i Cristiani.’ Mi chiese: ‘E cosa dicevano?’ Risposi: ‘Dicevano: Ascoltiamo e disobbediamo!’ ‘E i credenti cosa dicono!’ E io: «‘Dicono: Ascoltiamo e obbediamo’». ‘Dici il vero!’, disse: ‘Chiedi, e ti sarà dato.’ Io allora dissi: «‘O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo!’» Lui replicò: ‘Già ho tolto da te e dalla tua Comunità” la punizione per “l’errore e la dimenticanza, e” per “ciò che non piace loro!’ Poi dissi: «‘O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi’», e cioè agli Ebrei, e Lui disse: ‘E sia, per te e per la tua Comunità.’ Quindi dissi: «‘O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere!’» Disse: ‘Già ho fatto!’ Continuai: «‘Usaci Clemenza, perdonaci e di noi abbi Misericordia! Tu sei il nostro Patrono: dacci vittoria sul popolo dei negatori!’» ‘Già fatto!,’ concluse.” Dicono Al-Qurtubî e As-Samarqandî: “Si tramanda da Al-Hasan, da Mugiâhid e da Ad-Dahhâk che questo versetto entra nella narrazione dell’Ascensione. Lo stesso si tramanda in molte versioni da Ibn ‘Abbâs. V’è anche chi dice che tutto il Corano fu fatto discendere su Muhammad
negli hadith riguardanti l’Ascensione: [Quando ebbi superato il Loto del Limite,] Allah mi fece avvicinare, mi approssimò al sostegno del Trono, poi mi ispirò di dire ‘«L’Inviato ha Fede in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore, assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati», come invece facevano gli Ebrei e i Cristiani.’ Mi chiese: ‘E cosa dicevano?’ Risposi: ‘Dicevano: Ascoltiamo e disobbediamo!’ ‘E i credenti cosa dicono!’ E io: «‘Dicono: Ascoltiamo e obbediamo’». ‘Dici il vero!’, disse: ‘Chiedi, e ti sarà dato.’ Io allora dissi: «‘O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo!’» Lui replicò: ‘Già ho tolto da te e dalla tua Comunità” la punizione per “l’errore e la dimenticanza, e” per “ciò che non piace loro!’ Poi dissi: «‘O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi’», e cioè agli Ebrei, e Lui disse: ‘E sia, per te e per la tua Comunità.’ Quindi dissi: «‘O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere!’» Disse: ‘Già ho fatto!’ Continuai: «‘Usaci Clemenza, perdonaci e di noi abbi Misericordia! Tu sei il nostro Patrono: dacci vittoria sul popolo dei negatori!’» ‘Già fatto!,’ concluse.” Dicono Al-Qurtubî e As-Samarqandî: “Si tramanda da Al-Hasan, da Mugiâhid e da Ad-Dahhâk che questo versetto entra nella narrazione dell’Ascensione. Lo stesso si tramanda in molte versioni da Ibn ‘Abbâs. V’è anche chi dice che tutto il Corano fu fatto discendere su Muhammad tramite l’Angelo Gibrîl, ad eccezione di questo versetto, che fu udito direttamente dal Profeta
tramite l’Angelo Gibrîl, ad eccezione di questo versetto, che fu udito direttamente dal Profeta la notte dell’Ascensione (…). Quando il Profeta
la notte dell’Ascensione (…). Quando il Profeta fu salito ed ebbe raggiunto assieme a Gibrîl un luogo elevatissimo nei Cieli, passando oltre il Loto del Limite, l’Angelo gli disse: ‘Io non posso oltrepassare questo luogo, ed a nessuno a parte te è stato ordinato di oltrepassarlo.’ Il Profeta
fu salito ed ebbe raggiunto assieme a Gibrîl un luogo elevatissimo nei Cieli, passando oltre il Loto del Limite, l’Angelo gli disse: ‘Io non posso oltrepassare questo luogo, ed a nessuno a parte te è stato ordinato di oltrepassarlo.’ Il Profeta allora lo passò, e raggiunse il luogo che Allah volle raggiungesse. Gibrîl gli fece cenno di salutare il suo Signore, e il Profeta
allora lo passò, e raggiunse il luogo che Allah volle raggiungesse. Gibrîl gli fece cenno di salutare il suo Signore, e il Profeta disse: ‘Ad Allah appartengono i saluti vivificanti, le preghiere e ogni cosa buona e soave!’ Allah l’Altissimo gli rispose: ‘La Pace su di te, o Profeta, assieme alla Misericordia di Allah e alle Sue Benedizioni.’ Il Profeta
disse: ‘Ad Allah appartengono i saluti vivificanti, le preghiere e ogni cosa buona e soave!’ Allah l’Altissimo gli rispose: ‘La Pace su di te, o Profeta, assieme alla Misericordia di Allah e alle Sue Benedizioni.’ Il Profeta volle che giungesse alla sua Comunità una parte di questo saluto, e disse: ‘La Pace su di noi, e sui servi di Allah buoni ed integri.’ Allora Gibrîl e tutti gli abitanti dei Cieli dissero: ‘Testimonio che non v’è divinità all’infuori di Allah, e testimonio che Muhammad è Suo servo e Suo Inviato.[3] Ecco che Allah l’Altissimo disse: «‘L’Inviato ha Fede’» nel senso del ringraziamento e della veridicità da parte sua, «‘in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore’». Il Profeta
volle che giungesse alla sua Comunità una parte di questo saluto, e disse: ‘La Pace su di noi, e sui servi di Allah buoni ed integri.’ Allora Gibrîl e tutti gli abitanti dei Cieli dissero: ‘Testimonio che non v’è divinità all’infuori di Allah, e testimonio che Muhammad è Suo servo e Suo Inviato.[3] Ecco che Allah l’Altissimo disse: «‘L’Inviato ha Fede’» nel senso del ringraziamento e della veridicità da parte sua, «‘in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore’». Il Profeta volle associare la propria Comunità a tale onore ed eccellenza, e disse: «‘Assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati’», nel senso che essi dicono ‘Abbiamo Fede in tutti gli Inviati e non ne rinneghiamo nessuno, né facciam differenza tra loro come invece facevano gli Ebrei e i Cristiani.’ Il Signore allora chiese ‘In che modo essi hanno recepito i versetti che ho fatto discendere?’ (…) L’Inviato di Allah
volle associare la propria Comunità a tale onore ed eccellenza, e disse: «‘Assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati’», nel senso che essi dicono ‘Abbiamo Fede in tutti gli Inviati e non ne rinneghiamo nessuno, né facciam differenza tra loro come invece facevano gli Ebrei e i Cristiani.’ Il Signore allora chiese ‘In che modo essi hanno recepito i versetti che ho fatto discendere?’ (…) L’Inviato di Allah rispose: «‘Dicono: Ascoltiamo e obbediamo! Il Tuo Perdono, o nostro Signore! E verso di Te è il Divenire’» e cioè il ritorno. Allora Allah disse: «‘Allah non impone a un’anima se non ciò di cui essa è capace’» di sopportare, o, secondo alcuni, non impone se non meno di quel che è capace di sopportare: «‘ad essa va ciò che consegue’» di bene, «‘e contro di essa è ciò che commette’» di male. Gibrîl disse a questo punto: ‘Chiedi, che ti sarà dato.’ Il Profeta
rispose: «‘Dicono: Ascoltiamo e obbediamo! Il Tuo Perdono, o nostro Signore! E verso di Te è il Divenire’» e cioè il ritorno. Allora Allah disse: «‘Allah non impone a un’anima se non ciò di cui essa è capace’» di sopportare, o, secondo alcuni, non impone se non meno di quel che è capace di sopportare: «‘ad essa va ciò che consegue’» di bene, «‘e contro di essa è ciò che commette’» di male. Gibrîl disse a questo punto: ‘Chiedi, che ti sarà dato.’ Il Profeta allora disse: «‘O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo’» senza cioè averne conoscenza, «‘o sbagliamo’» volontariamente. Secondo alcuni il senso è ‘se operiamo nella dimenticanza o nell’errore.’ Gibrîl disse: ‘Già t’è stato concesso, ed è stata levata dalla tua Comunità la responsabilità per l’errore e la dimenticanza. Chiedi ancora.’ Disse: «‘O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi’», dato che Allah aveva loro vietato delle cose buone e soavi in ragione della loro ingiustizia, così che quando peccavano la notte trovavano la cosa scritta” al mattino “sulla porta della loro casa. Inoltre dovevano fare cinquanta preghiere. Allah allora alleggerì il peso per questa Comunità islamica, facendo cadere parte di quel che aveva reso obbligatorio, e cioè cinquanta preghiere. Poi disse: «‘O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere’», che questa sarebbe punizione per noi, o diciamo ci risulterebbe penoso. Erano stati incaricati di cinquanta preghiere, cosa che sarebbero stati capaci di reggere, ma che alla lunga sarebbe risultata penosa e non l’avrebbero sopportata, così che le preghiere furon ridotte a cinque. «‘Usaci Clemenza, perdonaci’», e cioè passa oltre. Si dice che il senso sia «‘Usaci Clemenza’» e risparmiaci la mutazione sfigurante, «‘perdonaci’» ed evitaci la punizione dello sprofondare sottoterra, «‘e di noi abbi Misericordia’» facendo sì che non siamo diffamati; le Comunità anteriori venivano infatti punite con la mutazione sfigurante, oppure facendole sprofondare, o con la diffamazione. «‘Tu sei il nostro Patrono’», e cioè il nostro Amico e Protettore: «‘Dacci vittoria sul popolo dei negatori!’» E fu risposto affermativamente alla sua invocazione.”
allora disse: «‘O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo’» senza cioè averne conoscenza, «‘o sbagliamo’» volontariamente. Secondo alcuni il senso è ‘se operiamo nella dimenticanza o nell’errore.’ Gibrîl disse: ‘Già t’è stato concesso, ed è stata levata dalla tua Comunità la responsabilità per l’errore e la dimenticanza. Chiedi ancora.’ Disse: «‘O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi’», dato che Allah aveva loro vietato delle cose buone e soavi in ragione della loro ingiustizia, così che quando peccavano la notte trovavano la cosa scritta” al mattino “sulla porta della loro casa. Inoltre dovevano fare cinquanta preghiere. Allah allora alleggerì il peso per questa Comunità islamica, facendo cadere parte di quel che aveva reso obbligatorio, e cioè cinquanta preghiere. Poi disse: «‘O nostro Signore, non ci caricare di ciò che non abbiam la forza di reggere’», che questa sarebbe punizione per noi, o diciamo ci risulterebbe penoso. Erano stati incaricati di cinquanta preghiere, cosa che sarebbero stati capaci di reggere, ma che alla lunga sarebbe risultata penosa e non l’avrebbero sopportata, così che le preghiere furon ridotte a cinque. «‘Usaci Clemenza, perdonaci’», e cioè passa oltre. Si dice che il senso sia «‘Usaci Clemenza’» e risparmiaci la mutazione sfigurante, «‘perdonaci’» ed evitaci la punizione dello sprofondare sottoterra, «‘e di noi abbi Misericordia’» facendo sì che non siamo diffamati; le Comunità anteriori venivano infatti punite con la mutazione sfigurante, oppure facendole sprofondare, o con la diffamazione. «‘Tu sei il nostro Patrono’», e cioè il nostro Amico e Protettore: «‘Dacci vittoria sul popolo dei negatori!’» E fu risposto affermativamente alla sua invocazione.”
֎ «L’Inviato ha Fede in quel ch’è stato fatto discender su di lui» ecc. Anche solo dal punto di vista specificamente religioso, è evidente che v’è una differenza tra la ‘Fede’ del Profeta e la ‘Fede’ degli altri credenti: la prima, dice Al-Mâwardî, “consiste nel portare la Funzione di Inviato legiferante e trasmettere il Deposito tradizionale alla Comunità islamica, la seconda è Conferma e Opera.” Da un punto di vista più profondo, per dirla con parole riportate da As-Sulamî, “la Fede dell’Inviato di Allah
e la ‘Fede’ degli altri credenti: la prima, dice Al-Mâwardî, “consiste nel portare la Funzione di Inviato legiferante e trasmettere il Deposito tradizionale alla Comunità islamica, la seconda è Conferma e Opera.” Da un punto di vista più profondo, per dirla con parole riportate da As-Sulamî, “la Fede dell’Inviato di Allah è una Fede di Svelamento e di Contemplazione, mentre la Fede dei credenti è una Fede che ha luogo per mezzo di Mediazioni e Relazioni” con altre creature, che trasmettono loro gli insegnamenti profetici (o anche, dice Al-Alûsî, è una Fede di “Conseguimento dalla Nicchia del Profeta
è una Fede di Svelamento e di Contemplazione, mentre la Fede dei credenti è una Fede che ha luogo per mezzo di Mediazioni e Relazioni” con altre creature, che trasmettono loro gli insegnamenti profetici (o anche, dice Al-Alûsî, è una Fede di “Conseguimento dalla Nicchia del Profeta ”). Al-Qushayrî dice: “Tutte le creature hanno Fede in ragione della Prova, mentre l’Inviato
”). Al-Qushayrî dice: “Tutte le creature hanno Fede in ragione della Prova, mentre l’Inviato ha Fede in ragione della Visione diretta. (…) Che differenza tra una Fede e l’altra: le creature hanno Fede per deduzione, mentre tu, Muhammad, hai Fede per via di Realizzazione.” Dal punto di vista strettamente iniziatico infine si deve considerare, con Al-Mazharî, che “la vera Fede ha luogo solo dopo l’estinzione dell’anima, e l’eliminazione delle sue sporcizie.”
ha Fede in ragione della Visione diretta. (…) Che differenza tra una Fede e l’altra: le creature hanno Fede per deduzione, mentre tu, Muhammad, hai Fede per via di Realizzazione.” Dal punto di vista strettamente iniziatico infine si deve considerare, con Al-Mazharî, che “la vera Fede ha luogo solo dopo l’estinzione dell’anima, e l’eliminazione delle sue sporcizie.” 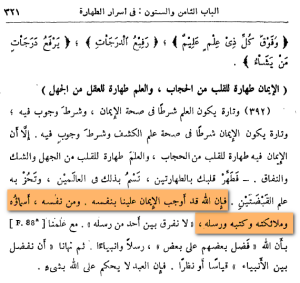
֎ «Ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. “Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati!”» Come dice Ibn ‘Arabî nelle Futûhât (1, 68, 357 – OY 5, 321), “Allah ci ha imposto la Fede in Lui stesso (بنفسه bi nafsi-hi), e fan parte di ‘Lui stesso’ i Suoi Nomi, i Suoi Angeli, i Suoi Libri e i Suoi Inviati.” A proposito del ‘non far differenza tra nessuno degli Inviati divini’, avendo Fede in tutti loro, Ibn ‘Arabî sviluppa alcune importanti considerazioni prendendo spunto da quanto avvenne a Medina quando il Profeta vide che gli Ebrei digiunavano il giorno di ‘Ȃshûrâ. Essendogli stato detto che essi digiunavano in obbedienza ad un’indicazione di Mûsâ, egli replicò: ‘Noi siam più degni di Mûsâ di quanto non lo siate voi,’ ed ordinò di digiunare anche il giorno prima e quello dopo, ordine che si trasformò in indicazione di eccellenza quando fu imposto l’obbligo del digiuno di Ramadan. Dice dunque Ibn ‘Arabî nelle Futûhât (1, 71, 635 – OY 9, 307-8): “Dice Allah l’Altissimo a proposito dei
vide che gli Ebrei digiunavano il giorno di ‘Ȃshûrâ. Essendogli stato detto che essi digiunavano in obbedienza ad un’indicazione di Mûsâ, egli replicò: ‘Noi siam più degni di Mûsâ di quanto non lo siate voi,’ ed ordinò di digiunare anche il giorno prima e quello dopo, ordine che si trasformò in indicazione di eccellenza quando fu imposto l’obbligo del digiuno di Ramadan. Dice dunque Ibn ‘Arabî nelle Futûhât (1, 71, 635 – OY 9, 307-8): “Dice Allah l’Altissimo a proposito dei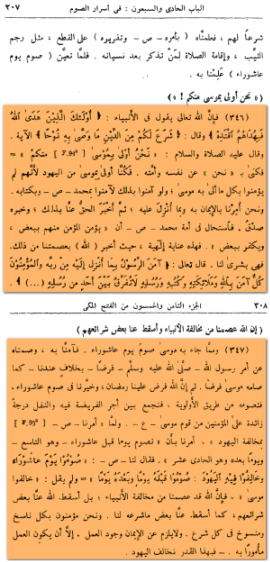 Profeti: «Essi son coloro che Allah ha guidato: segui dunque la loro Guida!» (VI, 90). E dice: «Ha prescritto a voi come Religione quanto raccomandò a Nûh, e ancora quel che abbiamo ispirato a te, e quanto abbiam raccomandato ad Ibrâhîm, a Mûsâ e a ‘Îsâ: innalzate la Religione, e non dividetevi su di essa» (XLII, 13). E ancora, il Profeta
Profeti: «Essi son coloro che Allah ha guidato: segui dunque la loro Guida!» (VI, 90). E dice: «Ha prescritto a voi come Religione quanto raccomandò a Nûh, e ancora quel che abbiamo ispirato a te, e quanto abbiam raccomandato ad Ibrâhîm, a Mûsâ e a ‘Îsâ: innalzate la Religione, e non dividetevi su di essa» (XLII, 13). E ancora, il Profeta dice [a proposito del digiuno di ‘Âshûrâ]: ‘Noi siam più degni di Mûsâ di quanto non lo siate voi!’ Qui per ‘noi’ egli intende lui stesso e la sua Comunità: ecco che siamo ‘più degni di Mûsâ di quanto non lo siate voi ebrei.’ Gli Ebrei infatti non hanno Fede in tutto quello che ha portato Mûsâ, perché se avessero Fede in tutto quel che ha portato avrebbero Fede anche in Muhammad
dice [a proposito del digiuno di ‘Âshûrâ]: ‘Noi siam più degni di Mûsâ di quanto non lo siate voi!’ Qui per ‘noi’ egli intende lui stesso e la sua Comunità: ecco che siamo ‘più degni di Mûsâ di quanto non lo siate voi ebrei.’ Gli Ebrei infatti non hanno Fede in tutto quello che ha portato Mûsâ, perché se avessero Fede in tutto quel che ha portato avrebbero Fede anche in Muhammad e nel suo Libro sacro; a noi viceversa è stato ordinato di aver Fede in lui e in quel che gli è stato rivelato. Quindi Dio dà notizia di questo a nostro riguardo, e il suo dar notizia è veritiero, di come cioè sia impossibile nella Comunità di Muhammad
e nel suo Libro sacro; a noi viceversa è stato ordinato di aver Fede in lui e in quel che gli è stato rivelato. Quindi Dio dà notizia di questo a nostro riguardo, e il suo dar notizia è veritiero, di come cioè sia impossibile nella Comunità di Muhammad che ‘un credente di loro abbia Fede in parte del Libro, e smentisca un’altra parte’: si tratta di divina Provvidenza, in quanto Allah dà notizia di come noi siamo preservati da questo, ciò che rappresenta una Buona Novella per noi. E dice l’Altissimo: «L’Inviato ha Fede in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore, assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. ‘Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati!’» E il giorno di ‘Ȃshûrâ fa parte di quel che ha portato Mûsâ: dunque abbiamo Fede in esso e digiuniamo in esso per ordine dell’Inviato di Allah
che ‘un credente di loro abbia Fede in parte del Libro, e smentisca un’altra parte’: si tratta di divina Provvidenza, in quanto Allah dà notizia di come noi siamo preservati da questo, ciò che rappresenta una Buona Novella per noi. E dice l’Altissimo: «L’Inviato ha Fede in quel che è stato fatto discender su di lui dal suo Signore, assieme ai credenti: ognuno ha Fede in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati. ‘Non facciam differenza tra nessuno dei Suoi Inviati!’» E il giorno di ‘Ȃshûrâ fa parte di quel che ha portato Mûsâ: dunque abbiamo Fede in esso e digiuniamo in esso per ordine dell’Inviato di Allah , e questo” all’inizio “obbligatoriamente (…), allo stesso modo in cui Mûsâ digiunava in esso obbligatoriamente; poi Allah ci ha imposto il digiuno di Ramadan, e ci ha dato possibilità di scegliere” se digiunare o meno “il giorno di ‘Âshûrâ, e noi digiuniamo in esso nel senso del compiere quel che è preferibile. In tal modo noi riuniamo la ricompensa dell’atto obbligatorio e quella dell’atto surerogatorio, come grado concesso ai credenti rispetto al popolo di Mûsâ. Quando poi il Profeta
, e questo” all’inizio “obbligatoriamente (…), allo stesso modo in cui Mûsâ digiunava in esso obbligatoriamente; poi Allah ci ha imposto il digiuno di Ramadan, e ci ha dato possibilità di scegliere” se digiunare o meno “il giorno di ‘Âshûrâ, e noi digiuniamo in esso nel senso del compiere quel che è preferibile. In tal modo noi riuniamo la ricompensa dell’atto obbligatorio e quella dell’atto surerogatorio, come grado concesso ai credenti rispetto al popolo di Mûsâ. Quando poi il Profeta ci ordinò di segnare una differenza con gli Ebrei, ci ordinò di digiunare il giorno prima di ‘Âshûrâ, e cioè il nove di Muharram, e il giorno dopo, e cioè l’undici, dicendoci: ‘Digiunate il giorno di ‘Âshûrâ, e differenziatevi in esso dagli Ebrei: digiunate un giorno prima di esso e un giorno dopo.’ Egli non ci ha detto: ‘Differenziatevi da Mûsâ’, che Allah ci ha preservato dal contraddire i Profeti. Piuttosto, Egli ha invalidato per noi parte delle loro Norme sacre, allo stesso modo in cui ha invalidato per noi parte di quel che ci aveva imposto,” abrogando cioè parti della stessa Rivelazione coranica: “e noi siamo credenti di ogni cosa rivelata, che sia abrogante od abrogata, e in ogni Legge sacra, che la Fede non implica necessariamente la messa in atto dell’opera, a meno che essa non sia ordinata. Tale la misura in cui contraddiciamo gli Ebrei.” In altre parole, la Fede obbligatoria in tutti gli Inviati e in tutti i Libri sacri impone ai Musulmani di non contraddire in nulla né gli uni né gli altri, e consiste nell’aver Fede in tutte le Tradizioni divine precedenti l’Islam ‘storico’, anche se sono ‘abrogate’ nella loro efficacia legale dalla Rivelazione coranica.
ci ordinò di segnare una differenza con gli Ebrei, ci ordinò di digiunare il giorno prima di ‘Âshûrâ, e cioè il nove di Muharram, e il giorno dopo, e cioè l’undici, dicendoci: ‘Digiunate il giorno di ‘Âshûrâ, e differenziatevi in esso dagli Ebrei: digiunate un giorno prima di esso e un giorno dopo.’ Egli non ci ha detto: ‘Differenziatevi da Mûsâ’, che Allah ci ha preservato dal contraddire i Profeti. Piuttosto, Egli ha invalidato per noi parte delle loro Norme sacre, allo stesso modo in cui ha invalidato per noi parte di quel che ci aveva imposto,” abrogando cioè parti della stessa Rivelazione coranica: “e noi siamo credenti di ogni cosa rivelata, che sia abrogante od abrogata, e in ogni Legge sacra, che la Fede non implica necessariamente la messa in atto dell’opera, a meno che essa non sia ordinata. Tale la misura in cui contraddiciamo gli Ebrei.” In altre parole, la Fede obbligatoria in tutti gli Inviati e in tutti i Libri sacri impone ai Musulmani di non contraddire in nulla né gli uni né gli altri, e consiste nell’aver Fede in tutte le Tradizioni divine precedenti l’Islam ‘storico’, anche se sono ‘abrogate’ nella loro efficacia legale dalla Rivelazione coranica.
֎ «“O nostro Signore, non ci punire se dimentichiamo o sbagliamo!”» Come ricorda Al-Mazharî, l’aspetto più evidente di queste parole coraniche è recepito dalla Legge sacra, per la quale non v’è alcun peccato se, ad esempio, si cade addormentati o si dimentica di fare una delle preghiere obbligatorie, o si sbaglia nella considerazione del tempo in cui effettuarla: in tali casi, il tempo loro proprio è quello in cui ci si sveglia o ci si ricorda della cosa, oppure ci si rende conto dell’errore (anche se apparentemente il tempo loro proprio è già trascorso).
֎ «“O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi”». Al-Qurtubî ricorda il hadith in cui il Profeta dice: “La Religione è facilità: rendete le cose facili, e non rendetele difficili.” Al-Qushayrî dice: “Quando dissero ‘«O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi»’, Allah fece sprofondare i loro peccati, al posto della punizione che consisteva, nelle Comunità precedenti, nel far sprofondare i peccatori; e trasformò i loro peccati in opere belle, al posto della mutazione sfigurante che colpiva quelli; e fece discendere su di loro la Misericordia, e posto delle pietre che faceva scendere sulle Comunità peccatrici che vennero prima dell’Islam.” Dice Ibn ‘Agîba: “Si tratta dell’Amore di Allah: il servo non chieda dell’Amore del proprio Patrono se non quello che può sopportare! Consideri la storia di quell’uomo che chiese a Mûsâ che Allah gli concedesse in provvidenza il Suo Amore; ecco che quando Mûsâ invocò il suo Signore in tal senso, quello prese a vagare senza meta, si stracciò le vesti, sino a che gli si lacerarono le giunture e morì. Mûsâ allora chiese al suo Signore della condizione di quell’uomo, e Lui gli disse: ‘O Mûsâ, mille uomini mi hanno tutti chiesto quel che mi ha chiesto quell’uomo, ed io ho diviso il Mio Amore tra tutti loro, e a lui è toccata quella parte.’ ” La Via di quanti ottengono la Realizzazione e la Conoscenza metafisica, dice sempre Ibn ‘Agîba, è differente: “Essi giungono alla quiete dopo il duro lavoro, e arrivano alla contemplazione dell’Amato ed al colloquio con Colui che è Vicino. La loro adorazione è nel cuore, la loro opera è interiore, tra riflessione ed esoterica considerazione, assieme a coloro che rimangono nella Presenza. Il loro desiderio è placato, la loro angoscia è svanita: hanno bevuto e son stati irrigati, son divenuti ebbri, e poi sobri. Gli stati non li smuovono, le parole non li agitano, che sono come delle montagne saldissime: Allah ci dia giovamento nella loro menzione, e ci faccia della loro schiera!” Di queste due Vie, la prima è paragonabile almeno in parte a quello che in occidente di definisce ‘misticismo’, mentre la seconda descrive la Realizzazione seguente al percorrere la Via iniziatica regolare, che presuppone un atteggiamento attivo e la profonda intellezione degli stati spirituali che si attraversano.
dice: “La Religione è facilità: rendete le cose facili, e non rendetele difficili.” Al-Qushayrî dice: “Quando dissero ‘«O nostro Signore, non farci portare un peso gravoso, come quello che hai fatto portare a quei che son venuti prima di noi»’, Allah fece sprofondare i loro peccati, al posto della punizione che consisteva, nelle Comunità precedenti, nel far sprofondare i peccatori; e trasformò i loro peccati in opere belle, al posto della mutazione sfigurante che colpiva quelli; e fece discendere su di loro la Misericordia, e posto delle pietre che faceva scendere sulle Comunità peccatrici che vennero prima dell’Islam.” Dice Ibn ‘Agîba: “Si tratta dell’Amore di Allah: il servo non chieda dell’Amore del proprio Patrono se non quello che può sopportare! Consideri la storia di quell’uomo che chiese a Mûsâ che Allah gli concedesse in provvidenza il Suo Amore; ecco che quando Mûsâ invocò il suo Signore in tal senso, quello prese a vagare senza meta, si stracciò le vesti, sino a che gli si lacerarono le giunture e morì. Mûsâ allora chiese al suo Signore della condizione di quell’uomo, e Lui gli disse: ‘O Mûsâ, mille uomini mi hanno tutti chiesto quel che mi ha chiesto quell’uomo, ed io ho diviso il Mio Amore tra tutti loro, e a lui è toccata quella parte.’ ” La Via di quanti ottengono la Realizzazione e la Conoscenza metafisica, dice sempre Ibn ‘Agîba, è differente: “Essi giungono alla quiete dopo il duro lavoro, e arrivano alla contemplazione dell’Amato ed al colloquio con Colui che è Vicino. La loro adorazione è nel cuore, la loro opera è interiore, tra riflessione ed esoterica considerazione, assieme a coloro che rimangono nella Presenza. Il loro desiderio è placato, la loro angoscia è svanita: hanno bevuto e son stati irrigati, son divenuti ebbri, e poi sobri. Gli stati non li smuovono, le parole non li agitano, che sono come delle montagne saldissime: Allah ci dia giovamento nella loro menzione, e ci faccia della loro schiera!” Di queste due Vie, la prima è paragonabile almeno in parte a quello che in occidente di definisce ‘misticismo’, mentre la seconda descrive la Realizzazione seguente al percorrere la Via iniziatica regolare, che presuppone un atteggiamento attivo e la profonda intellezione degli stati spirituali che si attraversano.
֎ «“Usaci Clemenza, perdonaci e di noi abbi Misericordia”». Dice Ismâ‘îl Haqqî: “Il fatto che la richiesta della Clemenza e del Perdono preceda quella della Misericordia è dovuto al fatto che”, secondo il noto detto iniziatico, “lo svuotamento (تخلية takhliyya) viene prima dell’ornamento (تحلية tahliyya).”
֎ «“Tu sei il nostro Patrono: dacci vittoria sul popolo dei negatori”», “e questo,” come dice Al-Qushayrî, “in ogni stato, perché noi non abbiamo nessuno al di fuori di Te: Tu sei il nostro Patrono, concedici la Vittoria su quello che ci distrae da Te.” Secondo quanto riportato da Al-Gazâlî, citato da An-Nawawî nel Kitâbu l-adhkâr, benché la cosa non abbia assolutamente il carattere di una prescrizione, o di una sunna, “i veri sapienti e i membri delle gerarchie esoteriche (ابدال abdâl) non superano nelle loro invocazioni le sette espressioni invocatorie,” ciò che sarebbe confermato appunto nel presente versetto finale della Sura della Vacca Sacrificale, in cui abbiamo sette invocazioni: 1) non ci punire per la dimenticanza, e neppure per l’errore; 2) non farci portare un peso gravoso; 3) non caricarci di quel che non possiamo reggere; 4) abbi clemenza per noi, 5) perdonaci, 6) ed usaci misericordia; 7) dacci vittoria. La stessa cosa, dice An-Nawawî, si trova nella Sura di Ibrâhîm: «Quando Ibrâhîm disse: “Signore, rendi questo Paese sicuro, e allontana me e i miei figli dall’adorazione degl’idoli, o Signore, che essi molti uomini han fatto errare! E chi mi seguirà sarà dei miei, mentre quanto a chi mi disobbedisce, ebbene Tu sei Perfetto nel perdono, e Clementissimo. O nostro Signore, faccio risiedere parte della mia discendenza in una vallata priva di coltivazioni, presso la Tua sacra Casa, o Signore nostro, affinché essi innalzino la preghiera. Fa sì che i cuori di certi uomini abbian predilezione per loro, e dà loro frutti in provvidenza, che possan ringraziare! O nostro Signore, Tu ben conosci ciò che teniamo nascosto e ciò che palesiamo: e nulla può restar nascosto ad Allah, in terra come in Cielo. La Lode spetta ad Allah, che mi ha donato nonostante la vecchiaia Ismâ‘îl e Ishâq: e invero il mio Signore dell’Invocazione è Udente! Signore, fa che io innalzi la preghiera, e così la mia discendenza, o nostro Signore, e accetta la mia Invocazione! Signore nostro, perdona a me, ai miei genitori ed ai credenti, il Giorno in cui s’innalza il Rendiconto!”» (XIV, 35-41). Anche qui abbiamo infatti sette invocazioni: 1) rendi sicuro il paese; 2) allontanaci dall’adorazione degli idoli; 3) fai che i cuori di certi uomini abbiano predilezione per chi abita presso la Santa Casa; 4) dai loro frutti in provvidenza; 5) fai che io e la mia discendenza innalziamo l’Invocazione; 6) accetta l’Invocazione; 7) perdona a me, ai miei genitori e ai credenti.
֎ “At-Tabarî tramanda che quando Muâdh terminava la Sura recitando «‘Dacci vittoria sul popolo dei negatori’», diceva ‘Âmîn!’ ” La cosa si riporta anche dal Profeta . Al-Alûsî riporta infatti da Abû Maysara: “Gibrîl ispirò all’Inviato di Allah
. Al-Alûsî riporta infatti da Abû Maysara: “Gibrîl ispirò all’Inviato di Allah di dire al termine della Sura della Vacca Sacrificale: ‘آمين Âmîn!’ ”
di dire al termine della Sura della Vacca Sacrificale: ‘آمين Âmîn!’ ”
NOTE:
[1] Secondo altri hadith il ‘Loto del Limite’ sarebbe al settimo Cielo; An-Nawawî ricorda che i due diversi dati tradizionali si spiegano nel senso che le radici di tale ‘Loto’ sarebbero nel sesto Cielo.
[2] La parte del Corano detta mufassal va dalla Sura 49 (o secondo alcuni dalla Sura 45, o dalla Sura 50) sino al termine del Testo sacro. Essa viene suddivisa tradizionalmente in tre parti: le ‘Sure lunghe’ del mufassal, dalla Sura 49 sino grosso modo alla Sura 78; le sue ‘Sure centrali’, da questa sino alla Sura 93; e le sue ‘Sure corte’, fino al termine del Corano.”
[3] Tutte le voci di questo dialogo vengono recitate dagli oranti durante la preghiera, ed intendiamo le parole “Ad Allah appartengono i saluti vivificanti, le preghiere e ogni cosa buona e soave! La Pace su di te, o Profeta, assieme alla Misericordia di Allah e alle Sue Benedizioni. La Pace su di noi, e sui servi di Allah buoni ed integri. Testimonio che non v’è divinità all’infuori di Allah, e testimonio che Muhammad è Suo servo e Suo Inviato.”